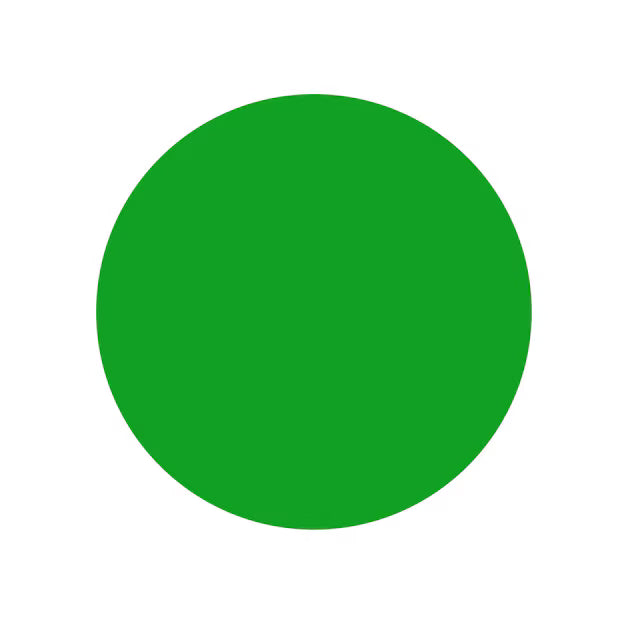Pure Elettroliti
Pure Elettroliti
Idratazione durante i periodi di forte calore o durante e dopo uno sforzo intenso o di resistenza.
🕑 Posologia
Per bustina (10 g): 5 minerali essenziali (Na, Ca, Mg, Zn e K) e 3 vitamine (B1, B2 e C).
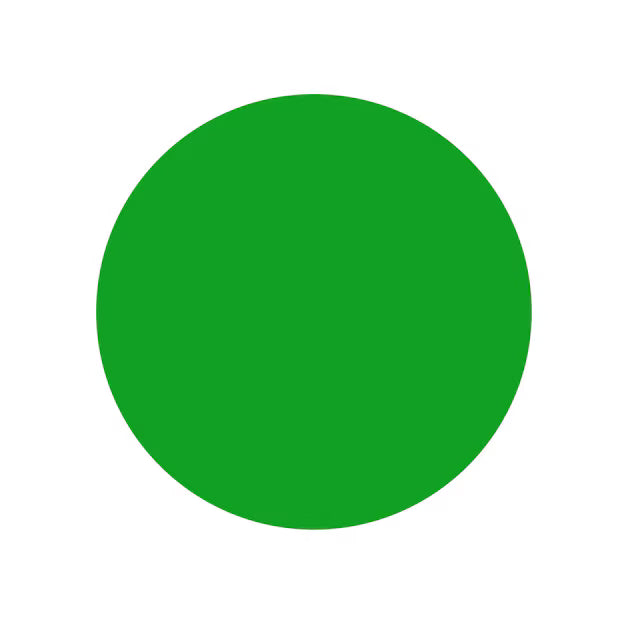 Preparación en 24h
Preparación en 24h
¿Para quién?
¿Para quién?
Sportivi durante uno sforzo intenso (corsa, crossfit, trail, ciclismo), persone nei periodi di forte calore o durante i viaggi per evitare la disidratazione.
Consejos de uso
Consejos de uso
Diluire 1 bustina (10 g) in 500–800 ml d’acqua durante lo sforzo, oppure in 250–500 ml per l’idratazione generale (caldo, viaggio).
Ingredientes claves
Ingredientes claves
Formula con 5 elettroliti (Na, Ca, Mg, Zn e K) e 3 vitamine (B1, B2 e C). Aroma naturale di limone o frutti rossi. Senza edulcoranti.
Descripción
Descripción
Polvere per bevanda che apporta 5 minerali essenziali e 3 vitamine per mantenere l’equilibrio dell’organismo (omeostasi), favorire il metabolismo energetico e garantire una buona reidratazione.

Pure Elettroliti
Que los clientes hablen por nosotros
Maxime G.
Elettroliti piacevoli ed efficaci
Un gusto molto gradevole, poco dolce e meno stucchevole rispetto ai classici elettroliti. Molto pratici per il reintegro di elettroliti prima, durante o dopo una sessione sportiva.
Sabine.A
Prodotto di qualità
Prodotto di qualità e, soprattutto, senza zucchero, proprio quello che cercavo. Provato nel gusto limone: alla fine è abbastanza neutro, con un aroma leggero e piuttosto gradevole.
Formato pratico, lo porto sempre nella mia borsa da palestra e lo uso quando faccio più sessioni di cross training e ciclismo di seguito.
Patrice M.
L’indispensabile!!!
Elettroliti di qualità, senza zucchero, da usare senza moderazione per tutto il giorno. Si combina perfettamente con maltodestrina e BCAA.
Gusto limone e frutti rossi eccellente, né dolce né stucchevole nel tempo come accade con altre marche concorrenti!
Il top!
Anthony W.
Finalmente degli elettroliti SENZA edulcoranti!
Utilizzo questi elettroliti in bustina per recuperare dopo alcuni allenamenti intensi, per rimineralizzarmi e sfruttare il potere alcalinizzante dei citrati minerali.
Il gusto è leggero e piuttosto gradevole, mescolato in 500 ml d’acqua che bevo durante la giornata.
GRANDE PUNTO POSITIVO: finalmente degli elettroliti senza edulcoranti (né artificiali né a base di stevia)! (Forse gli unici sul mercato?)
David H.
Pure Elettroliti
Lo uso principalmente d’estate durante gli allenamenti con forte caldo… E funziona davvero! Nessun calo di rendimento, prevenzione della fatica muscolare, ecc.
Ottimo prodotto, lo consiglio al 100%!

Composizione
Gusto Limone
Zucchero di canna, citrato di potassio, citrato di calcio, citrato di magnesio, sale marino non raffinato, citrato di sodio, aroma naturale di limone, gluconato di zinco, vitamina C (acido ascorbico), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (cloridrato di tiamina).
Effettuiamo un'accurata pulizia contro gli allergeni tra una produzione e l'altra, ciononostante sussiste un rischio di presenza di allergeni con possibili tracce di: latte.
Gusto Frutti Rossi
Zucchero di canna, citrato di potassio, citrato di calcio, citrato di magnesio, sale marino non raffinato, citrato di sodio, aromi naturali frutti rossi, colorante: succo di barbabietola (maltodestrina), gluconato di zinco, vitamina C (acido ascorbico), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (cloridrato di tiamina).
Effettuiamo un'accurata pulizia contro gli allergeni tra una produzione e l'altra, ciononostante sussiste un rischio di presenza di allergeni con possibili tracce di: latte.
Denominazione legale
Preparato in polvere per bevanda a base di elettroliti, gusto limone.
Informazioni Nutrizionali
Gusto Limone
(tableau)
Gusto Frutti Rossi
(tableau)
Confezionamento
15 bustine da 10g.
Avvertenze
Sconsigliato a donne in gravidanza o in allattamento. Riservato agli adulti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non usare in sostituzione di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. È indispensabile bere almeno 1,5L di acqua al giorno.
Consigli per l'uso
Per sforzi brevi (meno di 1 ora e 30 minuti)
Gli elettroliti sotto forma di bevanda sono particolarmente adatti per sforzi in cui la sudorazione è significativa. Questo è il caso degli sport al chiuso come la pesistica, il crossfit e gli sport di resistenza di durata inferiore a 1 ora e 30 minuti come la corsa, la mountain bike... L'apporto di minerali, oltre al leggero apporto di zuccheri (6g per bustina), è ideale per migliorare il recupero.
Diluire 1 bustina di elettroliti in 500 ml a 800 ml d'acqua e bere la bevanda durante tutta l'attività fisica, a piccoli sorsi.
Raccomandazioni di idratazione
500 ml per ora di sforzo per temperature inferiori a 10° C
600-700 ml per ora di sforzo per temperature comprese tra 10°C e 20°C.
800ml a 1L per ora di sforzo per temperature superiori a 20°C
Per sforzi lunghi (più di 1 ora e 30 minuti)
Durante uno sforzo lungo (maratona, trail, triathlon, ciclismo), il corpo non ha solo bisogno di essere idratato, ma ha anche bisogno di energia sotto forma di carboidrati. Associati alla maltodestrina, gli elettroliti si rivelano una combinazione ottimale per mantenere le prestazioni e aumentare l'assorbimento dell'acqua nell'organismo.
Diluire 1 bustina di elettroliti in 500 a 800 ml d'acqua + 50g di maltodestrina e bere la bevanda durante tutta l'attività fisica, a piccoli sorsi.
Raccomandazioni di idratazione
500 ml per ora di sforzo per temperature inferiori a 10°C
600-700ml per ora di sforzo per temperature comprese tra 10°C e 20°C
800ml a 1L per ora di sforzo per temperature superiori a 20°C
Il clima
L'assunzione di elettroliti non è riservata unicamente agli sportivi. Infatti, in caso di forte calore come le ondate di calore, la sudorazione comporta la perdita di minerali preziosi. Per evitare la disidratazione, il corpo ha bisogno di acqua ma anche di un apporto di elettroliti per garantire il corretto funzionamento dell'organismo.
Diluire 1 bustina di elettroliti in 1 bicchiere grande d'acqua (circa $250$ ml).
In viaggio
Che vi spostiati per piacere o per lavoro, viaggiare moltiplica i rischi di disidratazione. La causa principale è l'aria particolarmente secca che circola nei mezzi di trasporto (autobus, treno, aereo), negli aeroporti, o i problemi gastrici (esempio: dissenteria del viaggiatore). Una bevanda a base di elettroliti vi farà il massimo bene per contrastare i sintomi della disidratazione.
Diluire 1 bustina di elettroliti nella vostra borraccia o bottiglia d'acqua (circa 500 ml).
Elementi indispensabili per l'equilibrio del vostro organismo
Gli elettroliti (Calcio, Potassio, Sodio, Magnesio, Zinco) svolgono un ruolo vitale nel nostro corpo. La loro presenza sufficiente è indispensabile per il buon funzionamento muscolare, per il mantenimento di un buon livello di idratazione del corpo e per l'equilibrio acido-base.
- Gli elettroliti sono essenziali per permettere alle fibre muscolari di contrarsi e rilassarsi, in particolare il sodio, il potassio, il calcio e il magnesio.
- Gli elettroliti e in particolare il sodio permettono di regolare il volume d'acqua contenuto nell'organismo. Una quantità elevata di elettroliti consente al corpo di immagazzinare più acqua e quindi di favorire la sua reidratazione.
- Gli elettroliti sono minerali che trasportano una carica elettrica nei fluidi corporei (acqua e sangue). La loro presenza mantiene l'equilibrio acido-base.
Pure Electrolytes combina il know-how scientifico con l'esperienza dello sport di alto livello per farvi beneficiare della migliore idratazione possibile.
Evitare la disidratazione e il calo delle prestazioni
Sudando, il corpo elimina fino a $1,5$ litri d'acqua all'ora. Durante un'attività di resistenza (maratona, trail, ciclismo...), il corpo elimina fino a $3$ litri d'acqua all'ora. La sudorazione comporta anche un'importante eliminazione di sali minerali (il vostro sudore è salato!).
Se l'alimentazione quotidiana apporta sufficienti minerali in condizioni normali, un aumento dell'attività sportiva e quindi della sudorazione richiede un apporto supplementare di sali elettrolitici.
Poiché il livello di elettroliti nel corpo condiziona il suo livello di idratazione, l'atleta cercherà di ricostituire queste riserve di elettroliti per facilitare la sua reidratazione.
Un leggero livello di disidratazione (1-2%) comporta una diminuzione del 10% della vostra capacità fisica.
Pure Electrolytes permetterà una buona idratazione e quindi di mantenere un livello di performance costante durante lo sforzo.
Rafforzare la funzione muscolare
La contrazione muscolare assicura la motricità del corpo. Questa funzione muscolare è sotto il controllo del sistema nervoso somatico. Il cervello invia messaggi ai muscoli sotto forma di stimolazione nervosa affinché avvenga una contrazione muscolare.
Il sodio e il potassio sono responsabili della trasmissione del sistema nervoso. Quando il cervello chiede al muscolo di contrarsi, il sodio entra nella cellula nervosa mentre il potassio ne esce. L'inverso avviene quando il muscolo si rilassa.
Questa stimolazione nervosa provoca l'arrivo di ioni calcio nelle cellule muscolari, permettendo al muscolo di contrarsi, e l'uscita di questi stessi ioni calcio, affinché il muscolo si rilassi. Quanto al magnesio, il suo ruolo è quello di regolare l'entrata e l'uscita degli ioni calcio nelle vostre cellule muscolari.
L'importanza dell'equilibrio acido-base
Determinato dal pH, l'equilibrio acido-base dell'organismo è vitale per la salute. I polmoni e i reni utilizzano il potassio, il magnesio e il calcio per regolare il livello di pH nel sangue al fine di trovare l'equilibrio acido-base.
Un'alimentazione ricca di zuccheri o una pratica sportiva intensa possono generare un eccesso di acidità nel sangue. Per contrastare questo squilibrio, l'organismo attinge alle sue riserve minerali (calcio, potassio, magnesio).
Questa demineralizzazione comporta numerosi problemi di salute a lungo termine: fragilità ossea, artrosi, dolori e indurimento muscolare, tensione a livello della schiena e della nuca.
Un apporto di elettroliti permette di compensare questa demineralizzazione.
Recuperare meglio con gli elettroliti
Studi hanno dimostrato che le persone che sudano a seguito di uno sforzo fisico o durante forte calore sono tutte in deficit elettrolitico (sodio, zinco, magnesio...). Poiché il corpo non sa sintetizzarli, gli elettroliti sono apportati esclusivamente attraverso l'alimentazione e un'idratazione ricca di sali minerali.
Sfortunatamente, è stato dimostrato che l'acqua da sola non è sufficiente a coprire il fabbisogno degli sportivi dopo un'attività fisica che comporta sudorazione.
A seguito di uno sforzo, un'idratazione combinata con il sodio faciliterà il recupero. Il magnesio e le vitamine B2 e C miglioreranno questo recupero poiché svolgono un ruolo nel ridurre la stanchezza.
Pure Electrolytes contiene tutti i nutrienti essenziali per un buon recupero.
Elettroliti
Presentazione generale
Gli elettroliti sanguigni sono microminerali (minerali di cui l'organismo ha bisogno in grandi quantità) che circolano nell'organismo e sono indispensabili per il suo corretto funzionamento. Questi minerali portano una carica, positiva o negativa, e sono quindi caratterizzati come ioni (sali, basi e acidi). La presenza di tali composti nel plasma sanguigno rende quest'ultimo un elettrolita, che conduce la corrente elettrica. Gli elettroliti sono essenziali per l'organismo, essendo coinvolti in fenomeni fisiologici come il mantenimento dell'equilibrio acido-base e dell'osmolarità. (1)
Tra gli elettroliti sanguigni, si distinguono i cationi, caricati positivamente come sodio, potassio, calcio, magnesio, e gli anioni, caricati negativamente come il cloro o il bicarbonato. In tutti i liquidi fisiologici, la neutralità elettrica deve essere mantenuta e il numero di cariche positive deve essere equivalente alle cariche negative. Tutte queste proprietà consentono loro di regolare la funzione nervosa e muscolare, oltre a mantenere l'equilibrio idrico. (2)
Scelta delle forme utilizzate
Tutti i minerali hanno ruoli ben specifici all'interno dell'organismo. Qui, saranno dettagliate le funzioni di questi minerali in quanto elettroliti e il loro interesse nelle funzioni fisiologiche che coinvolgono le loro proprietà fisico-chimiche. Pertanto, non saranno dettagliati tutti i ruoli di ogni minerale, ci concentreremo sulle proprietà elettrolitiche di ciascuno.
Zinco: gluconato: è un sale di due anioni di gluconato per un catione di zinco. È una forma altamente biodisponibile. Il suo contenuto di zinco è meno elevato rispetto al citrato di zinco, ad esempio, ma la sua solubilità è molto migliore.
Sodio: citrato e sale di Guérande (se la granulometria del sale di Guérande lo permette). Il citrato di sodio è il sale sodico dell'acido citrico. Ha un potere alcalinizzante, quindi è molto usato nell'industria alimentare per ridurre l'acidità delle bevande gassate, ad esempio. Nell'organismo, si ritrova questo potere alcalinizzante e può essere utilizzato nella gestione delle acidosi renali.
Potassio: citrato. Per un apporto di potassio, i citrati rappresentano una fonte ben assimilabile dall'organismo con un'elevata biodisponibilità.
Magnesio: citrato, è la forma che ha il miglior rapporto contenuto/biodisponibilità. L'acido citrico, un acido organico a basso peso molecolare, favorisce l'assorbimento del magnesio aumentandone la solubilità. Il citrato di magnesio è una forma ben tollerata.
Calcio: citrato: forma meglio assorbita rispetto al carbonato di calcio. Il citrato di calcio è assorbito il 25% in più rispetto al carbonato di calcio e, inoltre, non necessita di un ambiente acido per essere assorbito.
Proprietà del sodio
Il sodio o Na+è un elemento predominante nel sangue e nei liquidi extracellulari del corpo. È il principale catione extracellulare. Il suo ruolo principale è il mantenimento dell'equilibrio idrico tra i diversi compartimenti dell'organismo e assicurare un'idratazione ottimale delle cellule.
Infatti, l'acqua segue gradienti di concentrazione passivi. Vale a dire che passa da un compartimento all'altro senza dispendio di energia e in funzione dei gradienti di concentrazione. L'acqua passerà sempre dall'ambiente meno concentrato a quello più concentrato. Ad esempio, durante la sudorazione, il corpo è disidratato e si ha meno sodio nel sangue a causa delle perdite dovute al sudore. Tuttavia, si ha anche meno acqua, quindi le conseguenze sull'equilibrio sono poco evidenti. È raro che un atleta soffra di iponatremia solo a causa della sudorazione. Il problema della sudorazione è più la disidratazione che la perdita di sodio, quindi è necessario idratarsi. Tuttavia, ciò che può essere pericoloso è idratarsi enormemente e rapidamente subito dopo aver sudato molto, perché si apporta molta acqua nel sangue che è impoverito di sodio. Ciò diluirà ancora di più il sodio nel sangue, e in questo caso si possono avere iponatremie e squilibri elettrolitici. È per questo che è necessario idratarsi con bevande integrate con elettroliti, per ristabilire l'equilibrio. L'acqua in un certo senso andrà a "diluire" l'ambiente troppo concentrato. Così, se un ambiente è ricco di Na+, l'acqua passerà in questo ambiente che sarà quindi idratato. Nell'esempio sopra, C1
Inoltre, il sodio è coinvolto nella regolazione della pressione arteriosa a livello renale. Questo si basa sulla proprietà vista in precedenza, dove l'acqua segue il sodio. Così, grazie a certi ormoni come la vasopressina, il sodio non viene eliminato e, al contrario, viene trattenuto nella circolazione sanguigna quando alcuni recettori rilevano un'ipovolemia (quando il volume sanguigno è basso, il flusso sanguigno è quindi debole). In questo modo, l'acqua seguirà e verrà trattenuta nella circolazione sanguigna, aumentando così il volume, il flusso sanguigno, e di conseguenza la pressione arteriosa sarà aumentata
Proprietà del potassio
Il potassio o K+ è anche uno dei principali elettroliti sanguigni. È il principale catione intracellulare. È essenziale per il normale funzionamento delle cellule, dei nervi e dei muscoli. Come il sodio, è necessario per il mantenimento dell'equilibrio dei fluidi impedendo la fuoriuscita dell'acqua dalle cellule. Il suo ruolo principale risiede nella trasmissione dell'impulso nervoso e nella contrazione muscolare.
Tutte le cellule hanno, a riposo, un potenziale di membrana chiamato potenziale di riposo. Il suo valore è di -70V ed è dovuto a una distribuzione delle cariche su entrambi i lati della membrana. Nello spazio intracellulare, si trovano principalmente gli ioni K+ che entrano nella cellula contro il loro gradiente di concentrazione e nello spazio extracellulare, si trovano principalmente gli ioni tNa+che vengono scambiati con il potassio tramite una pompa ATPasi. Quando un impulso nervoso viene trasmesso, il potenziale di membrana diventa positivo e si ha una depolarizzazione della membrana cellulare. I canali del sodio voltaggio-dipendenti si aprono, causando l'ingresso massivo di Na+ nella cellula. Parallelamente, i canali K+ si aprono e il potassio uscirà dalla cellula. Questo modificherà la distribuzione delle cariche intorno alla membrana e permetterà di trasmettere l'impulso nervoso. Durante la ripolarizzazione, c'è un ri-pompaggio degli ioni K+ verso l'interno della cellula da parte delle pompe ATPasi al fine di ristabilire il potenziale di riposo. (8)
Proprietà del magnesio
La maggior parte del magnesio nell'organismo è legata alle proteine o immagazzinata nelle ossa; in queste due forme è neutro e non ha carica. Nella sua forma libera, il magnesio è un catione chiamato anche Mg2+. L'osso contiene circa la metà del magnesio dell'organismo, il sangue ne contiene in realtà molto poco. Perciò, è essenziale per la formazione delle ossa, dei denti e contribuisce al normale funzionamento dei nervi e dei muscoli. (4)
In quanto elettrolita, il magnesio regola anche il trasferimento di altri elettroliti attraverso la membrana cellulare: gli ioni sodio e potassio sono coinvolti. Ad esempio, stimola la pompa sodio/potassio (enzima che permette l'ingresso di potassio nella cellula e l'uscita di sodio). Le funzioni biologiche dipendenti da questi movimenti ionici sono quindi sensibili alle variazioni extracellulari e intracellulari del magnesio. È il caso dell'eccitabilità cellulare che regola il tono vascolare, la vasomotricità, l'attività cardiaca e nervosa. (5)
L'equilibrio osmotico
Gli elettroliti partecipano al mantenimento dell'equilibrio osmotico. Quest'ultimo è essenziale per l'organismo e le conseguenze di uno squilibrio possono essere dannose per la nostra salute.
Definizioni e principi
Il principio di osmosi si basa sulla circolazione dei fluidi attraverso le membrane in funzione delle concentrazioni dei diversi soluti su entrambi i lati di tali membrane. Pertanto, se due soluzioni acquose con concentrazioni saline diverse sono separate da una membrana, l'acqua passerà dalla soluzione meno concentrata in soluto verso la soluzione più concentrata. L'acqua vorrà andare a "diluire" l'ambiente più concentrato al fine di ristabilire un equilibrio tra gli ambienti e conservare quella che viene chiamata osmosi. Il flusso di trasferimento di acqua da un ambiente all'altro è definito dalla pressione osmotica, forza motrice dell'acqua necessaria al ristabilimento dell'osmosi. Questa pressione osmotica è chiamata anche osmolarità, espressa in osmoli, che è rappresentata dal numero di particelle osmoticamente attive in una soluzione. (8)
L'acqua rappresenta il 60% del peso corporeo totale, distribuita nel modo seguente:
- 40% nello spazio intracellulare
- 20% nello spazio extracellulare, di cui:15% nell'ambiente interstiziale5% nello spazio intravascolare.
Il volume intracellulare dipende dalla pressione osmotica extracellulare, mentre il volume extracellulare dipende dalla quantità di Na+ presente nell'organismo. Così, la pressione osmotica intracellulare è determinata principalmente dal K+ e la pressione osmotica extracellulare è determinata principalmente dal Na+.
Ruolo degli elettroliti nell'equilibrio idrico
L'acqua attraversa liberamente le membrane cellulari dalle regioni a bassa concentrazione di soluti verso le zone ad alta concentrazione di soluti. Così, l'osmolalità tende a equilibrarsi nei diversi compartimenti liquidi corporei, essenzialmente tramite movimenti di acqua, ma non di soluti. (9)
I principali regolatori dell'equilibrio idrico sono il sodio e il potassio:
Il sodio: Il sodio determina il volume extracellulare; una disnatremia (quando il livello di sodio è anomalo, che sia troppo alto o troppo basso) è più frequentemente associata a uno squilibrio del volume extracellulare. I valori normali della natremia (concentrazione di sodio nel sangue) sono circa 135 a 145 mmol/L.
I meccanismi di regolazione sono:
- il sistema renina-angiotensina-aldosterone: l'ipovolemia stimola il rilascio di angiotensina II tramite la renina. L'angiotensina II provoca una vasocostrizione e stimola il rilascio di aldosterone, che favorisce il riassorbimento di sodio e l'escrezione di potassio, così come degli ioni idrogeno.
- l'ANP, il cui rilascio è stimolato dall'ipervolemia e dall'ipertensione, provoca una natriuresi;
- l'ADH, il cui rilascio è stimolato dall'iperosmolarità e dall'ipovolemia, favorisce il riassorbimento di acqua nel dotto collettore del nefrone.
Il potassio: il potassio si trova principalmente a livello intracellulare (90% del K+ è nelle nostre cellule). I valori normali della kaliemia (concentrazione di potassio nel sangue) si situano tra 3.5 e 5mmol/L. Il suo ruolo nell'equilibrio idrico è il suo scambio con il sodio. Infatti, il corpo regola le concentrazioni di sodio dei diversi compartimenti dell'organismo facendo passare il sodio da un compartimento all'altro, e l'acqua segue (1.2.1). Tuttavia, il sodio non passa sempre per diffusione passiva tra i diversi ambienti; talvolta utilizza una pompa ATPasi per passare in modo attivo contro il suo gradiente o per aumentare l'assorbimento del sodio in diverse situazioni (per esempio in caso di ipovolemia). Queste pompe ATPasi hanno bisogno di scambiare il Na+ con un altro minerale per funzionare, e questo minerale è il K+. 3Na+ sono scambiati con 2K+. (10)
Il rene secerne ioni potassio ogni volta che riassorbe ioni sodio. Il minimo aumento della concentrazione di potassio nel liquido extracellulare stimola il rilascio di aldosterone, la quale a sua volta stimola il riassorbimento del sodio e quindi l'eliminazione del potassio.
L'equilibrio acido-base
Gli elettroliti partecipano anche al mantenimento dell'equilibrio acido-base. Quest'ultimo è regolato da numerosi meccanismi, in particolare tramite i polmoni, i reni o i sistemi tampone. È determinato dal pH e uno squilibrio può avere conseguenze deleterie per l'organismo.
Definizioni e principi
Una caratteristica importante del sangue è il suo pH (grado di acidità o alcalinità). L'acidità o l'alcalinità di una soluzione, compreso il sangue, è espressa grazie alla scala del pH. La scala del pH varia da 0 (molto acido) a 14 (molto basico o alcalino). Un pH} a 7.0, al centro di questa scala, è neutro. Il sangue è normalmente leggermente basico, con un pH che varia tra circa 7.35 e 7.45. L'organismo mantiene abitualmente il pH sanguigno intorno a 7.40.
L'acidità del sangue aumenta quando:
- I livelli dei componenti acidi nell'organismo aumentano (per aumento dell'assunzione o della produzione, o per una diminuzione dell'eliminazione)
- I livelli dei composti basici (alcalini) nell'organismo diminuiscono (per una diminuzione dell'assunzione o della produzione, o un aumento dell'eliminazione).
Viceversa, l'alcalinità del sangue aumenta quando il livello di acido nell'organismo diminuisce o quando il livello della base aumenta. (11)
L'equilibrio acido-base del sangue è controllato con precisione, poiché un semplice piccolo scostamento dallo stato normale può danneggiare gravemente numerosi organi. L'organismo utilizza diversi processi per controllare l'equilibrio acido-base. Questi meccanismi coinvolgono diversi organi:
I polmoni: questo processo si basa sull'eliminazione di anidride carbonica attraverso i polmoni. L'anidride carbonica, che è leggermente acida, è un prodotto di scarto dell'elaborazione dell'ossigeno e dei nutrienti (necessari a tutte le cellule) e, come tale, è prodotta continuamente dalle cellule. Passa poi dalle cellule al sangue. Il sangue la trasporta ai polmoni dove viene eliminata durante l'espirazione. Se l'anidride carbonica si accumula nel sangue, il pH sanguigno diminuisce (l'acidità aumenta).
Il cervello regola la quantità di anidride carbonica espirata controllando la velocità e l'ampiezza della respirazione (ventilazione). La quantità di anidride carbonica eliminata e, di conseguenza, il pH del sangue, aumentano quando la respirazione diventa più rapida e più profonda. Modulando la velocità e l'ampiezza della respirazione, il cervello e i polmoni regolano il pH del sangue di minuto in minuto.
I reni: possono modificare il pH del sangue eliminando l'eccesso di acidi o di basi. I reni hanno la capacità di alterare la quantità di acido o base che viene escreta. Tuttavia, a causa del fatto che i reni producono questi adattamenti in modo più lento rispetto ai polmoni, la correzione del pH richiede in genere diversi giorni.
Sistemi tampone: impediscono le variazioni brusche di acidità e alcalinità. I sistemi tampone del pH sono miscele di acidi e basi deboli prodotti naturalmente nell'organismo. Questi acidi e basi deboli esistono in coppie che sono in equilibrio in condizioni normali di pH. I sistemi tampone sono sistemi chimici che limitano le variazioni di pH di una soluzione modificando i rapporti tra acido e base. Il sistema tampone del sangue più importante è l'acido carbonico un acido debole formato dall'anidride carbonica disciolta nel sangue) e lo ione bicarbonato (la base debole corrispondente). (11)
Esistono due anomalie dell'equilibrio acido-base:
- Acidosi: si tratta di un eccesso di acidi nel sangue (o di un deficit di basi) che comporta una diminuzione del pH sanguigno.
- Alcalosi: si tratta di un eccesso di basi nel sangue (o di un deficit di acidi) che comporta un aumento del pH sanguigno.
L'acidosi e l'alcalosi non sono malattie, ma la conseguenza di una grande varietà di disturbi. Sono il segno di uno stato patologico grave. (11)
Ruoli degli elettroliti nell'equilibrio acido-base
Diversi elettroliti entrano in gioco nel mantenimento dell'equilibrio acido-base. Troviamo in particolare il potassio, il magnesio e il calcio:
(a) Ruolo del Calcio
Diverse ricerche hanno dimostrato che un'acidosi cronica provoca una perdita di calcio dall'osso (12). Le riserve di calcio, che costituiscono il 99% del totale, sono le prime a essere intaccate da una variazione del pH sanguigno. Il calcio viene utilizzato per neutralizzare gli ioni idrogeno se l'equilibrio acido-base non è preservato. L'acidosi metabolica stimola l'attività degli osteoclasti (cellule che distruggono la sostanza ossea) e diminuisce l'attività degli osteoblasti (cellule che elaborano la sostanza ossea fondamentale). L'osteoporosi può quindi essere spiegata, in parte, come una conseguenza dello squilibrio acido-base. (14)
(b) Ruolo del Magnesio
Il magnesio è il secondo minerale chiamato in causa per fungere da tampone contro gli ioni acidi. L'organismo attinge ancora una volta dallo scheletro, poiché l'osso è composto da calcio ma anche dal 40% di magnesio. È un componente di oltre 3.000 enzimi, alcuni dei quali sono coinvolti nella contrazione muscolare, nel trasporto di ossigeno e nella sintesi proteica. Per questo motivo, una carenza di magnesio si manifesta con crampi e indolenzimento muscolare.
(c) Ruolo del Potassio
Il potassio viene anch'esso utilizzato dall'organismo per contrastare l'aumento del pH sanguigno. Aiuta a combattere l'acidificazione delle cellule. Svolge un ruolo di primo piano a livello dei reni, dove serve a compensare gli effetti nefasti di un'alimentazione troppo ricca di sale, a sua volta all'origine di una perdita di calcio osseo. Poiché le riserve di potassio si trovano nei muscoli, una carenza di potassio può aggiungersi al fenomeno dei crampi osservato in caso di carenza di magnesio. (13)
Conseguenze dello Squilibrio e Fonti Alimentari
Attingendo alle sue riserve minerali di calcio, magnesio e potassio per neutralizzare gli eccessi di acidità, l'organismo innesca un processo di demineralizzazione che comporta fragilità ossea, carie dentarie e artrosi. Una sensazione di dolore diffuso, indurimento muscolare, tensione a livello della schiena, della nuca e delle articolazioni possono ostacolare la mobilità.
- Gli alimenti più acidificanti sono lo zucchero bianco e i dolciumi, la farina bianca e i suoi derivati, i grassi induriti, gli oli raffinati, i brodi grassi, l'alcol, il caffè e il tè. Sono anche fornitori di acidi, ma in misura minore, le carni, il pesce, l'albume d'uovo, i formaggi forti e fermentati e i legumi.
- Gli alimenti alcalinizzanti o generatori di basi sono le verdure (con l'eccezione di carciofo, asparago, cavolini di Bruxelles, cipolla e porro), i succhi e i brodi di verdura, la frutta e i suoi succhi (tranne albicocca, arancia e prugna secca), la frutta secca, le erbe aromatiche, la patata, la mandorla, l'avocado, l'oliva, la soia e i suoi derivati, il latte, lo yogurt, la ricotta, il tuorlo d'uovo e le tisane. (15)
Definizioni e principi
La contrazione del muscolo striato scheletrico è legata alla precedente eccitazione delle fibre muscolari da parte dei motoneuroni alfa. Questa eccitazione porta infine allo scorrimento dei filamenti sottili e spessi gli uni sugli altri. I fenomeni che si verificano tra l'eccitazione e la contrazione sono definiti accoppiamento eccitazione-contrazione.
La genesi del potenziale d'azione della fibra muscolare, che è all'origine della contrazione, avviene a livello della placca motrice tramite una stimolazione nervosa. Quando un potenziale d'azione arriva a livello della terminazione assonale, la membrana nervosa si depolarizza. Questa depolarizzazione induce l'apertura dei canali del calcio voltaggio-dipendenti (ovvero sensibili alla differenza di potenziale tra la membrana plasmatica del motoneurone e lo spazio sinaptico). Il flusso di calcio all'interno della terminazione assonale innesca una fusione delle vescicole di acetilcolina con la membrana, il che induce il rilascio di questo mediatore nella fessura sinaptica. L'acetilcolina diffonde in questa fessura e si legherà a recettori specifici situati a livello della membrana post-sinaptica. Questi recettori sono recettori-canale.
Così il legame di due molecole di acetilcolina con il recettore induce un cambiamento nella conformazione del recettore che porta all'apertura del canale. Un flusso di ioni sodio nella fibra muscolare produce una depolarizzazione della membrana, si parla di potenziale di placca motrice. Quando questo potenziale raggiunge un valore soglia, induce l'apertura dei canali del sodio voltaggio-dipendenti a livello del sarcoplasma, generando così un potenziale d'azione. Questo potenziale d'azione si propaga sulla superficie della fibra muscolare in entrambe le direzioni verso le estremità della fibra muscolare, poiché la giunzione neuromuscolare è situata al centro della fibra muscolare. (16)
Ruoli degli elettroliti nella funzione muscolare
Diversi elettroliti giocano un ruolo nella contrazione del muscolo. Il calcio, menzionato in precedenza (4.1), è uno dei principali attori della funzione muscolare. Tuttavia, altri elettroliti come il sodio, il potassio e il magnesio sono essenziali per la buona salute dei nostri muscoli.
(a) Sodio e Potassio
Il sodio e il potassio sono essenziali per la funzione nervosa. I nervi inviano un potenziale d'azione per ordinare alle cellule muscolari di contrarsi.
- A riposo, il sodio è a concentrazioni più elevate all'esterno delle cellule muscolari, e il potassio è più elevato all'interno.
- Quando un nervo invia il segnale di contrazione a una fibra muscolare, il sodio entra rapidamente nella cellula e, simultaneamente, il potassio esce.
- Queste fasi si invertono quando un muscolo si rilassa (il sodio si sposta fuori dalla cellula e il potassio rientra).
(b) Calcio
Il calcio è un attore chiave della contrazione:
- In uno stato di rilassamento, il calcio si trova alle concentrazioni più elevate nel reticolo sarcoplasmatico.
- Quando la cellula è eccitata da un impulso nervoso (grazie all'afflusso di sodio), l'afflusso di sodio nella fibra muscolare innesca il rilascio di calcio dal reticolo sarcoplasmatico nel citoplasma della cellula.
- Il calcio lavora con proteine specializzate nella cellula per attivare un processo chiamato "teoria dei filamenti scorrevoli", in cui le proteine scivolano l'una sull'altra causando la contrazione muscolare (4.1).
- Quando il calcio si sposta nuovamente verso il reticolo sarcoplasmatico, la fibra si allunga di nuovo e si decontrae.
(c) Magnesio
Il magnesio è coinvolto nel rilassamento e compete con il calcio:
A riposo, il magnesio si lega alle proteine motrici all'interno della cellula e aiuta lo stato di rilassamento.
Nello stato contratto, dopo il rilascio di calcio dal reticolo sarcoplasmatico, il calcio ha un'affinità molto più elevata per le proteine motrici rispetto al magnesio e, di conseguenza, lo sposta.
In condizioni di carenza di magnesio, si possono osservare crampi muscolari. (29)
Squilibri elettrolitici
Gli elettroliti partecipano a numerosi meccanismi fisiologici e permettono di mantenere l'omeostasi all'interno del nostro organismo. Tuttavia, diversi fattori possono essere all'origine di disordini elettrolitici, che possono influenzare il nostro organismo e le nostre prestazioni se si pratica un'attività sportiva.
Origine delle carenze elettrolitiche
Ci sono numerose cause delle carenze elettrolitiche nel nostro corpo, che provocano squilibri:
La sudorazione intensa: che sia dovuta a un’attività fisica intensa o a un forte calore, la traspirazione causa una perdita di acqua e, allo stesso tempo, di sodio. Quando la temperatura ambientale supera la temperatura corporea, la sudorazione è l’unico meccanismo che permette di ridurre il calore dell’organismo. In situazioni di calore esterno elevato, essa può comportare una perdita di 1,7 litri d’acqua all’ora, ossia 1000 kcal/ora. Questa rapida perdita d’acqua è accompagnata da una perdita di sali dell’organismo. Questa perdita di sale è necessaria per compensare tali perdite e mantenere l’osmosi, tanto più che la termoregolazione è prioritaria rispetto alla regolazione riguardante l’acqua e il Na+. Anche in caso di disidratazione importante, la secrezione di sudore continua se le condizioni esterne lo richiedono. Il sodio viene eliminato volontariamente in modo attivo dal corpo, perché, poiché si perde acqua, se non si eliminasse sodio, si avrebbe ipernatriemia e le cellule si disidraterebbero molto rapidamente (l’acqua uscirebbe dalle cellule per andare nel sangue). Le perdite di cloruro di sodio (NaCl) sono di circa 2–2,5 g per litro di sudore (cioè 800–1000 mg di sodio Na) al giorno in uno sportivo che si allena moderatamente. Le perdite di potassio attraverso il sudore sono moderate, e un’alimentazione equilibrata copre i fabbisogni giornalieri (tra 3 e 5 g). Le deficienze e carenze sono molto rare. (31)
La pratica di un’attività sportiva aumenta le perdite, in particolare attraverso la sudorazione (30–40 mg di magnesio per litro di sudore per ora), ma anche a livello metabolico (reazioni enzimatiche); da qui l’interesse, per alcune persone, di fare cicli di magnesio marino, generalmente ben assimilato dall’organismo. In caso di forte sudorazione, le perdite di zinco possono arrivare fino a 5 mg/giorno. A titolo informativo, gli apporti nutrizionali consigliati in zinco sono di 12 mg/giorno per un uomo adulto. Si può quindi supporre che l’integrazione di zinco durante uno sforzo intenso, in ambiente caldo e/o di lunga durata (> 2 h), possa rivelarsi utile. (30)
La composizione del sudore varia in base agli individui e ai tipi di esercizio; tuttavia, studi hanno dimostrato che, dopo uno sforzo che provoca traspirazione, i soggetti presentavano tutti un deficit elettrolitico (in particolare di sodio). È stato inoltre dimostrato che una semplice idratazione non è sufficiente per ristabilire l’equilibrio e che è necessaria un’integrazione per evitare crampi e poter continuare ad allenarsi normalmente in seguito. Infatti, il reintegro delle perdite dovute al sudore è essenziale per un buon recupero dopo lo sforzo. (17)
L’età: con l’avanzare degli anni, il nostro corpo ha sempre più difficoltà a mantenere l’equilibrio elettrolitico. Ciò può spiegarsi con una riduzione dell’efficienza dei reni o con una cattiva alimentazione (ricca di alimenti acidi che alterano l’equilibrio acido-base, per esempio). Inoltre, il sistema digestivo può essere danneggiato, il che ostacola l’assorbimento dei minerali.
Si tratta più di un fattore di rischio che di una vera e propria causa di squilibrio elettrolitico. Nelle persone anziane è stato dimostrato che l’iponatriemia e l’ipokaliemia sono le anomalie elettrolitiche più comuni. (18) Con l’invecchiamento, la massa muscolare viene sostituita dal grasso. La massa idrica totale del corpo diminuisce quindi, e il volume intracellulare cambia. Tutti questi fattori giocano un ruolo nell’aumento della prevalenza dei disturbi elettrolitici negli anziani.
I problemi digestivi: le diarree e i vomiti provocano perdite idriche molto importanti. È essenziale compensare queste perdite non solo con una buona idratazione, ma anche con un’integrazione di elettroliti, poiché tali disturbi comportano una perdita concomitante di questi ultimi. (19)
I problemi renali: poiché i reni svolgono un ruolo indispensabile nell’equilibrio elettrolitico, un loro malfunzionamento provoca disturbi e un cattivo mantenimento dell’omeostasi. I reni non riescono più a mantenere l’equilibrio idrico ed elettrolitico. (20)
Conseguenze di una carenza di elettroliti
Ogni deficit di elettroliti può provocare diversi sintomi. Analizzeremo ciascun elettrolita singolarmente per descrivere i sintomi di ogni carenza.
Iponatriemia: l’iponatriemia è una diminuzione della concentrazione plasmatica di sodio < 136 mmol/L. Le manifestazioni cliniche sono principalmente neurologiche (dovute a un trasferimento osmotico di acqua nelle cellule cerebrali), in particolare nei casi di iponatriemia acuta, e comprendono cefalee, confusione e torpore; possono insorgere convulsioni e coma. La diagnosi si basa sulla misurazione della natriemia. Il dosaggio degli ioni nel sangue e nelle urine, l’osmolalità plasmatica e urinaria e la valutazione del volume permettono di determinarne la causa. Il trattamento consiste nella riduzione dell’apporto idrico, in un aumento dell’eliminazione dell’acqua, nella compensazione di eventuali deficit di sodio e nella cura del disturbo sottostante. (21)
Ipokaliemia: l’ipokaliemia è una concentrazione sierica di potassio < 3,5 mmol/L causata da un deficit delle riserve totali corporee di K+ o da uno spostamento anomalo del potassio verso l’interno delle cellule. La causa più frequente è una perdita renale o digestiva eccessiva. I sintomi clinici comprendono debolezza muscolare e poliuria; in caso di ipokaliemia severa può verificarsi un’iper-eccitabilità cardiaca. La diagnosi si basa sulla misurazione del potassio sierico. Il trattamento consiste nella somministrazione di potassio e nella cura della causa dell’ipokaliemia. (22)
Ipocalcemia: l’ipocalcemia è definita da una concentrazione plasmatica totale di calcio < 2,20 mmol/L in presenza di una concentrazione normale di proteine plasmatiche, oppure da un calcio plasmatico ionizzato < 1,17 mmol/L. Le cause più frequenti sono l’ipoparatiroidismo, la carenza di vitamina D e le nefropatie. I sintomi comprendono parestesie, tetania e, nei casi gravi, convulsioni, encefalopatia e insufficienza cardiaca. La diagnosi prevede la misurazione della calcemia con adeguamento alla concentrazione di albumina sierica. Il trattamento consiste nella somministrazione di calcio, talvolta associato a vitamina D. (23)
Ipomagnesemia: l’ipomagnesemia corrisponde a una concentrazione sierica di magnesio < 0,70 mmol/L. Le cause comprendono un apporto o un’assorbimento inadeguato di magnesio, oppure un’aumentata escrezione dovuta a ipercalcemia o a farmaci come i diuretici. I segni clinici sono spesso dovuti a un’ipokaliemia e a un’ipocalcemia associate, e comprendono letargia, tremori, tetania, convulsioni e disturbi del ritmo cardiaco. Il trattamento si basa sulla somministrazione di magnesio. (24)
Controindicazioni ed effetti indesiderati
Gli effetti indesiderati delle soluzioni elettrolitiche sono gli effetti inversi delle conseguenze di una carenza. Così, se l’assunzione di elettroliti è eccessiva, si avranno gli effetti opposti: iperkaliemia, ipernatriemia, ipercalcemia e ipermagnesemia, che sono anch’essi dannosi per l’organismo.
Ipernatriemia: l’ipernatriemia è una concentrazione di sodio sierico > 145 mmol/L. Essa implica un deficit dell’acqua corporea totale rispetto al sodio corporeo totale, causato da un apporto d’acqua inferiore alle perdite. Il sintomo principale è la sete; le altre manifestazioni cliniche sono soprattutto neurologiche (legate a un trasferimento osmotico di acqua fuori dalle cellule) e comprendono confusione, ipereccitabilità neuromuscolare, convulsioni e, nei casi più gravi, coma. La diagnosi si basa sulla misurazione del sodio plasmatico e talvolta su altri esami. (25)
Iperkaliemia: l’iperkaliemia è una concentrazione sierica di potassio > 5,5 mmol/L, solitamente dovuta a una riduzione dell’escrezione renale di potassio o a uno spostamento anomalo del potassio fuori dalle cellule. Generalmente, diversi fattori concomitanti favoriscono l’iperkaliemia, come un aumento dell’apporto di potassio, farmaci che alterano l’escrezione renale di potassio, e patologie o lesioni renali acute o croniche. L’iperkaliemia può verificarsi anche in caso di acidosi metabolica, come nell’acidosi diabetica. Le manifestazioni cliniche sono di tipo neuromuscolare, con debolezza muscolare ed effetti cardiotossici che, se gravi, possono degenerare in fibrillazione ventricolare o asistolia. La diagnosi si basa sulla misurazione della kaliemia. (26)
Ipercalcemia: l’ipercalcemia corrisponde a una calcemia totale > 2,60 mmol/L o a un calcio sierico ionizzato > 1,30 mmol/L. Le principali cause comprendono l’iperparatiroidismo, l’intossicazione da vitamina D e il cancro. Le caratteristiche cliniche includono poliuria, stitichezza, debolezza muscolare, confusione e coma. La diagnosi si basa sul dosaggio del calcio plasmatico ionizzato. (23)
Ipermagnesemia: l’ipermagnesemia corrisponde a una concentrazione di magnesio > 1,05 mmol/L. La causa principale è l’insufficienza renale. I sintomi comprendono ipotensione, depressione respiratoria e, nei casi gravi, arresto cardiaco. La diagnosi si basa sulla misurazione della concentrazione sierica di magnesio. (27)
È importante tenere a mente che questi disturbi si verificano principalmente in caso di disfunzione di un sistema fisiologico, come i reni o la tiroide. Pertanto, una supplementazione ragionevole, alle dosi indicate sul sito NUTRIPURE, è sicura per una persona adulta in buona salute. Tuttavia, bisogna rimanere vigili in caso di alterazione della funzione renale o di problemi ormonali che potrebbero predisporre a un sovraccarico elettrolitico.
Conclusione generale
Gli elettroliti sono dunque i principali attori nel mantenimento dell’omeostasi dell’organismo. Questi minerali sono essenziali per il corretto funzionamento del corpo e vengono apportati esclusivamente attraverso l’alimentazione e l’idratazione, poiché non sono sintetizzati dal nostro organismo. Ciascuno di essi possiede proprietà proprie e caratteristiche specifiche, ma agiscono anche in sinergia per regolare l’equilibrio idrico, l’equilibrio acido-base e la funzione muscolare.
Questi elementi sono fondamentali e, rapidamente, in caso di forte calore o di attività fisica intensa, possono diventare carenti. Per questo motivo, è opportuno proporre un’integrazione di elettroliti per le persone a rischio di carenza, poiché l’idratazione da sola può talvolta risultare insufficiente a compensare la perdita di elettroliti. Per fornire un’integrazione completa, tali elettroliti sono associati a minerali e vitamine essenziali come lo zinco, la tiamina, la riboflavina o la vitamina C.
Bibliografia
(1) Dr Nadine Oboa. 2016. Le soluzioni per infusione e gli elettroliti. IFSI Charles Foix, Jean Ronstand.
(2) James L. Lewis. 2020. Presentazione degli elettroliti, Manuale MSD.
(3) ANSES. 2017. I minerali.
(4) A. Pointillart, L. Gueguen. 1978. Relazioni fisiologiche tra il magnesio e l’osso. Annales de biologie animale, biochimie, biophysique 18 (6), p.1247-1271.
(5) Magalie AVENSAC. 2018. Il magnesio nella gestione dello stress in farmacia. p.10-13.
(6) Pierre Allain. 2000. Farmacologia, i medicinali, Terza edizione.
(7) Ghishan, Fayez K. 1984. Trasporto di elettroliti, acqua e glucosio in caso di carenza di zinco, Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition - Volume 3 - Numero 4 - p. 608-612.
(8) James L. Lewis. 2020. Presentazione del ruolo del potassio nell’organismo. Manuale MSD.
(9) James L. Lewis. 2020. Equilibrio idrico e sodico. Manuale MSD, versione per professionisti della salute.
(10) IFSI. 2018. L’equilibrio idrico, elettrolitico e acido-base.
(11) James L. Lewis. 2020. Generalità sull’equilibrio acido-base. Manuale MSD, versione per il grande pubblico.
(12) Remya Rajan, Kripa Elizabeth Cherian, John Mathew, Hesarghatta Shyamsunder Asha, Nitin Kapoor, Thomas Vizhalil Paul. 2021. Osteomalacia conseguente a un’acidosi tubulare renale nel corso di una sindrome di Gougerot-Sjögren. Revue du Rhumatisme.
(13) F. Stucker, P. Saudan, E. Feraille, P-Y. Martin. 2007. Rev Med Suisse, volume 3, 32112.
(14) Université Médicale Virtuelle Francophone. 2011. Voce 319, Ipercalcemia.
(15) Christian Demigné, Marie-Jeanne Davicco & Véronique Coxam, Fonds Français Alimentation et Santé. 2013. Stato dell’arte: alimentazione ed equilibrio acido-base.
(16) Institut de myologie. 2020. Meccanismi della contrazione.
(17) Maughan RJ, Shirreffs SM. 1997. Recupero dopo esercizio prolungato: ripristino dell’equilibrio idrico ed elettrolitico. J Sports Sci. 15(3):297-303.
(18) Schlanger, Lynn E. et al. 2010. Elettroliti nell’invecchiamento. Progressi nella malattia renale cronica vol. 17,4 (2010): 308-19.
(19) Compendio di epato-gastro-enterologia, 2ª edizione – Parte “Conoscenze” – Ottobre 2012, a cura della CDU-HGE – Editions Elsevier-Masson.
(20) Yolanda Smith. Giugno 2019. Rumore e insufficienza renale acuta da elettroliti, News Medical Life Sciences.
(21) Horacio J. Adrogué, MD, e Nicolaos E. Madias, MD. 2000. Iponatriemia, The New England Journal of Medicine.
(22) F. John Gennari, M.D. 1998. Ipokaliemia, The New England Journal of Medicine.
(23) Patricia A. Schenck, Dennis J. Chew, Larry Allen Nagode, e Thomas J. Rosol. 2006. Disturbi del calcio, ipercalcemia e ipocalcemia. Capitolo 6, p.122-194.
(24) Zalman S. Agus. 1999. Ipomagnesemia, Journal of the American Society of Nephrology.
(25) Horacio J. Adrogué, M.D., e Nicolaos E. Madias, M.D. 2000. Ipernatriemia, The New England Journal of Medicine.
(26) Joyce C. Hollander-Rodriguez, M.D., e James F. Calvert, Jr., M.D. 2006. Iperkaliemia. Oregon Health & Science University, 73(2):283-290.
(27) James W. Van Hook, MD. Gennaio 1999. Ipermagnesemia. Volume 7, numero 1, p.215-223.
(28) Larry E. Johnson, MD, PhD. 2019. Revisione generale sulle vitamine. Manuale MSD, versione per professionisti della salute.
(29) Michael I. Lindinger e George J. F. Heigenhauser. 1991. Il ruolo dei flussi ionici nella fatica del muscolo scheletrico. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 69(2):246-253.
(30) Nicolas Aubineau. 2021. Sudorazione e sport. Dietista nutrizionista sportivo e clinico.
(31) La composizione elettrolitica del sudore normale dell’adulto. American Review of Respiratory Disease, 93(1), pp.62–69.